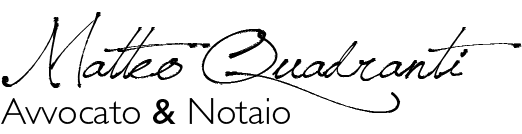Contattami:
12 marzo 2010 – Opinione Liberale Rubrica Ballate Maltesi
Tra diritto e indici (PIL, HDI, HPI)
La felicità è il giusto scopo della vita? Sì. Ogni mezzo è consentito pur di raggiungerla? Direi di no.
Uno stato di felicità fine a se stesso minaccerebbe cose cui diamo maggior valore: la nostra capacità di desiderare, impegnarci, migliorare, crescere inventare e scoprire. I beni primari sono la conoscenza e il progresso, la felicità un loro corollario. La felicità dipende dalla saggezza (Sofocle). Una vita degna di essere vissuta è certo una vita di benessere (non tanto, o solo, materiale) ma con la connotazione attiva dell’agire bene (cfr. concetto aristotelico di eudaimonía). Ciò deriva dall’uso della più alta facoltà umana, la ragione, che dovrebbe portarci a vivere con saggezza e giustizia (i.e. eticamente), perseguendo le virtù che si collocano nell’aurea via di mezzo. Così facendo si dovrebbe giungere ad essere “magnanimi” (dal latino “magna anima”), rispettosi e premurosi per gli altri, per la qualità della vita altrui, per le bellezze del mondo. Questa sarebbe una vita felice nel senso voluto da Shakespeare e dagli estensori della Costituzione degli USA, nel 18° sec., i quali indicarono “la vita, la libertà e la ricerca della felicità come diritti inalienabili di ogni individuo”.
La concretizzazione dei diritti è tuttavia ancora un bel problema. Per quel che riguarda la felicità, questa pare raggiunta in poche “isole della beatitudine” piuttosto che nell’Occidente industrializzato, ricco di offerte per il tempo libero e di beni di consumo. Almeno, stando all’Happy Planet Index (HPI) pubblicato nel 2006 dalla New Economy Foundation e organizzato anche dall’organizzazione ambientalista Friends of the Earth, le isole Vanuatu – nel mezzo dell’Oceano Pacifico – sono il Paese più felice del mondo (benché minacciato per ragioni climatiche). Di contro, gli Stati Uniti si collocano al 150° posto, la Germania all’81° (4° paese più felice in Europa), i paesi scandinavi tra il 112° e il 123°, il Kuweit al 159°, tanto per fare degli esempi. Dagli anni ’50 negli USA il reddito effettivo e il tenore di vita sono raddoppiati, ma la percentuale delle persone che si reputano felici non è aumentata, bensì rimasta uguale a quella di 50 anni fa. In un’inchiesta del 2005 del “Journal of Development Economics” su un campione di 350 mila europei e statunitensi, malgrado il PIL fosse aumentato in media del 2.1% all’anno, il benessere percepito è risultato diminuito. Quindi la felicità non aumenta proporzionalmente al reddito. Una possibile spiegazione? L’acquisizione può rendere felici, il possesso no. L’economia della felicità (Happiness Economics) è uno dei rami più promettenti della ricerca con cui si vuol misurare la serenità di un popolo (serenità = grado “zero” della felicità) e il successo dei governi, col metro, non più del PIL (Prodotto Interno Lordo), e nemmeno con il HDI (Human Development Index, che misurava anche l’aspettativa di vita e l’istruzione), bensì di un “Indice di Serenità Nazionale” o planetario. Tra questi economisti vi è Richard Layard della London School of Economics and Political Science, il quale rovescia la scala dei valori in essere attualmente. La maggior parte degli abitanti del ricco Occidente compra cose di cui non ha bisogno e, con dei soldi che in realtà spesso non ha, cerca di impressionare delle persone che magari neppure trova simpatiche. La crescita a cui ambiscono tutti i paesi industrializzati non produce uomini felici in modo duraturo. Eliminazione della disoccupazione e pace sociale sono più importanti della crescita del PIL. La mia felicità è l’attimo in cui sono profondamente in accordo con me stesso (Ludwig Marcuse, in “Filosofia della felicità”). L’aspetto più coinvolgente nella maggior parte delle situazioni di felicità, nel flirt, nel sesso, nel cibo, nei viaggi e a volte nello sport, è il gioco tra “attesa” e “realizzazione”. La felicità duratura è possibile solo laddove le aspettative restano coi piedi per terra. Se gli stati di felicità o infelicità sono per lo più “fatti in casa”, allora dipendono dal modo in cui ci rapportiamo con noi stessi. Solo così si spiega come persone che vivono periodi di difficoltà o situazioni di minor agio materiale possano essere più felici di altre più privilegiate. Essere in accordo con se stessi significa, come vorrebbe Marcuse, “essere in armonia con le proprie aspettative”. La neurofisiologia cerebrale ci spiega perché sia più facile ridere a Vanuatu che non da noi. La temperatura determina il temperamento, i raggi del sole sollevano l’umore provocando la secrezione di serotonina. Di contro, la caffeina, l’alcol, la nicotina o cocaina (tutti molto in uso nei paesi industrializzati) aumentano la secrezione di quel trasmettitore eccitante che è la dopamina. Questa provoca un’eccitazione gioiosa o una serenità di breve durata. Spiegare invece le condizioni di felicità più prolungate è tutta un’altra storia.
Sul concetto di felicità ebbero ad esprimersi anche J. Bentham a cui si contrappose il filosofo e politico liberale J. S. Mill. Il primo riteneva che la felicità equivaleva all’esperienza del piacere nel senso più vasto del termine, mentre il secondo voleva liberare l’utilitarismo dall’accusa di immaginare una felicità stupida e ottusa. Per questo egli attribuì maggior valore alle gioie dello spirito che a quelle del corpo: “Meglio essere un Socrate insoddisfatto che un maiale felice”. In breve egli attribuì un valore più alto ai desideri umani complessi. Questi due filosofi si posero comunque la domanda di come la ricerca della felicità di ogni singola persona potesse far nascere una società giusta giungendo alla conclusione che lo Stato era un “male necessario”. A tale visione si oppone quella di J. Rawls secondo il quale lo Stato è la sorgente delle leggi morali che fanno sì che una società giusta può portare alla libertà e quindi alla felicità di tutti. È questo il punto che forse segna ancora oggi la linea di confine tra i diversi schieramenti politici. Torniamo quindi ai diritti alla vita, alla libertà, alla felicità ed al senso di giustizia, nonché al ruolo dello Stato. Infine, se Adam Smith, considerato il padre della scienza economica, scrisse il suo trattato “Ricchezza delle nazioni” (PIL), da cui l’idea della “mano invisibile”, si dimentica però che di Smith è anche questa frase: “Per quanto egoista si possa ritenere l’uomo, sono chiaramente presenti nella sua natura alcuni principi che lo rendono partecipe delle fortune altrui, e che rendono per lui necessaria l’altrui felicità nonostante da essa egli non ottenga altro che il piacere di contemplarla” (HPI). Si tratta dell’Incipit della “Teoria dei sentimenti morali”.