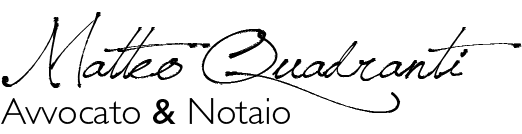Contattami:
12 luglio 2013 – Opinione Liberale, rubrica Ballate Maltesi
…e la Galleria mellonella.
“Quando contemplava i suoi alveari, Aurélien aveva la sensazione che quegli insetti fossero riusciti lì dove l’uomo aveva fallito. Pigiate le une contro le altre, le api mantenevano così una temperatura costante. Si adoperavano insieme per la comunità…durante la sua lenta evoluzione l’uomo si era pian piano ma sempre più allontanato dal paradiso. E si sorprese a sognare di diventare un ape”. Questo stralcio della favola “L’apicoltore” scritta da Maxence Fermine nel 2000 ci parla, tra l’altro, del sogno di un apicoltore di costituire Apipoli, una sorta di città delle api. Sogno mandato in fumo dalla “Galleria mellonella”, detta anche tarma della cera: una farfalla infestante degli alveari. Un altro appassionato di api fu il medico e filosofo olandese Bernard de Mandeville (1670 – 1733) il quale deve la sua fama al poema satirico “La Favola delle api: ovvero vizi privati, pubbliche virtù” pubblicato nel 1714. Tanto l’autore (esponente del libertinismo filosofico d’impronta materialista) quanto questa sua opera furono oggetto di ampie critiche, all’epoca e tuttora. Mandeville immagina un alveare operoso – la società inglese dell’epoca – in cui coesistono ricchezza e povertà, parassiti e sfruttatori, padroni e servi. Una società nella quale l’ape regina sopravvive solo grazie a uno stuolo di api cortigiane che la servono, mentre le classi agiate – i fuchi – passeggiano senza far nulla lasciando il duro lavoro alle misere api operaie che si affannano in lavori manuali per soddisfare i lussi e i vizi delle classi ricche. Ma un giorno il dio Giove decide di accontentare le richieste dei membri dell’alveare che lamentano le ingiustizie, le malversazioni, le frodi e la corruzione. Pertanto tutti diventano onesti e modesti, morigerati e frugali. Il risultato? Tanti che lavoravano per produrre beni di lusso, superflui, perdono il lavoro e l’alveare viene attaccato dal nemico che, se alla fine viene vinto, costringe le api a ritirarsi nel cavo di un albero dove non gli resterà altro se non accontentarsi dell’onestà. A Mandeville va sicuramente riconosciuto il merito di aver illustrato, in modo spietato, quello che Adam Smith prima e John M. Keynes poi chiamarono il “paradosso del risparmio”. In cosa consiste questo paradosso? Si tratta di guardare al risparmio in due modi diversi: il micro e il macro risparmio. Il primo è il risparmio individuale: quello che ognuno dovrebbe mettere da parte per i tempi difficili o per, ad es., l’acquisto di una casa. Tale risparmio è senz’altro una cosa giusta. Il secondo è il risparmio a livello collettivo. Se tutti si mettessero a risparmiare (ad es. usando tutto l’anno lo stesso abito), allora il denaro non circolerebbe più e l’economia si fermerebbe: il troppo risparmio spegne la caldaia che tiene sotto pressione l’apparato produttivo. Insomma, i vizi privati sono virtù pubbliche. L’affermazione è netta e controversa. Così come il troppo risparmio può essere un male, anche la troppa spesa può esserlo, se si spende quel che non si ha e ci si indebita eccessivamente. Mandeville fa un elogio del lusso e dello sperpero. Lo fa in modo caricaturale e va contestualizzato alla società dell’epoca che disapprovava per la propria ipocrisia puritana. Egli cerca di annientare la maledizione che gravava sull’idea dell’economia che vigeva sin dai tempi di Aristotele, il quale condannava la “cremastica”, ossia l’arte (immorale) dell’arricchirsi col commercio. Mandeville in breve sosteneva l’autonomia dell’economia dalla morale, in una visione liberista. Egli teorizzava che la creazione di ricchezza per il lussi delle classi agiate avrebbe “automaticamente” generato più prosperità per tutti. Anche le calamità e le guerre, a suo giudizio, erano fonte di prosperità poiché distruzione e morte consentivano di aprire cantieri di ricostruzione. I benefici relativi superavano la somma dei lutti. Mandeville fu incapace di cogliere i segni di una morale umanistica e laica capace di apprezzare quanto di buono vi era nello sviluppo tecnico e culturale della prima rivoluzione industriale separandolo dagli aspetti deteriori di asservimento e sfruttamento dell’uomo. Anche quando esalta il lusso seguendo le teorie liberiste, Mandeville dimostra di essere ancora sulla linea del capitalismo commerciale, secondo il quale la ricchezza consisteva soprattutto nella circolazione delle merci; egli non ha colto la novità del capitalismo industriale per il quale la condizione essenziale dello sviluppo e della ricchezza è rappresentato dall’accumulazione del capitale, cioè da quel risparmio, tipico dei severi puritani, che accumulando denaro, piuttosto che bruciarlo nel lusso, lo investivano generando produzione reale e ricchezza. Mandeville si concentrò su uno solo degli eccessi. Sta di fatto che il problema morale rimane e a tre secoli di distanza dalla Favola il persistere della miseria e della fame, dell’ampliarsi del divario tra ricchi e poveri ci fa dire che l’umanità non è ancora riuscita a conciliare questi due estremi. L’ineguaglianza resta un fenomeno complesso: non si lascia manipolare. Essa, malgrado le critiche della sinistra, è un’inevitabile prodotto dell’attività capitalistica, ma a dispetto di quanto pensano alcuni a destra, la diseguaglianza è un problema per tutti: oltre una certa soglia, l’ineguaglianza e l’insicurezza economica erodono l’ordine sociale e generano quei contraccolpi populisti contro il sistema capitalistico nel suo complesso. Prova ne è che tale situazione, aggravatasi negli ultimi 30 anni, non ha determinato uno spostamento a sinistra dell’opinione pubblica ma bensì la nascita di movimenti populisti. Pertanto, anche in una prospera Apipoli – dove tutte le api lavorano per il bene comune – bisogna stare attenti alle insidie di una “Galleria mellonella” che al suo interno possa infettarne il sistema. Joseph Stiglitz, premio Nobel per l’economia, intravvede un tale pericolo in quel 1% di straricchi che, usurpando il potere del popolo e minando la qualità della democrazia, piega le politiche pubbliche a proprio vantaggio. In fondo la morale di una favola assegna ancora i posti a tavola: dove siedono gli onesti, dove i farabutti. Ai giusti andrebbe garantito il lieto fine sociale, perché se “c’era una volta” non vi è motivo per cui non ci sia anche in futuro.
Matteo Quadranti, deputato PLR