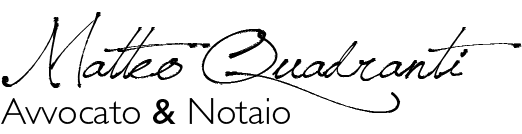Contattami:
Dicembre 2010 – Progresso sociale
Aiutiamo i giovani a recuperare le parole
Quando s’intende affrontare il tema dei giovani, e in particolare del disagio giovanile, è opportuno e doveroso premettere che si tratta di una minoranza di casi per rapporto alla gioventù in genere. Ho infatti conoscenza diretta di una moltitudine di giovani che s’impegnano negli studi, in attività di volontariato, in ambiti sportivi e anche politici, con anche importanti sacrifici in termini di tempo libero e doveroso ozio creativo. Tuttavia, visto che la politica deve occuparsi anche (se non soprattutto, come la giustizia d’altronde) dei problemi dei più deboli, mi paiono utili alcune riflessioni, fermo restando che il tema necessiterebbe di sviluppi ben più ampi e interdisciplinari. Innanzitutto il disagio giovanile, laddove e quando si manifesta, è un fenomeno “interclassista” nel senso che lo si trova sia nei ceti più bassi come in quelli più alti, nelle famiglie disgregate come in quelle apparentemente granitiche, nella povertà e nell’agiatezza. Nel destino di questi giovani “problematici”, la differenza risiede talvolta nelle risorse finanziarie o personali che i genitori possono o vogliono mettere a disposizione per la loro “difesa”. Difesa che non sempre s’accompagna a una vera educazione e responsabilizzazione, sin dalla più tenera età. Paradossalmente, nella società della comunicazione, sono venute meno le parole, o meglio, il senso di molte di esse. Ricerche scientifiche, mediche e criminologiche hanno dimostrato che i ragazzi più violenti possiedono strumenti linguistici scarsi o inefficaci, non sanno raccontare o dare conto delle ragioni, della successione, della dinamica di un evento, soprattutto quando è violento. Non sanno modulare lo stile della comunicazione in base agli interlocutori e al contesto. Ma soprattutto non sanno sentire e non sanno nominare le proprie emozioni che quindi vengono soffocate. Quando le parole fanno paura, e più di tutte proprio le parole che dicono la paura, la fragilità, la differenza, la tristezza; quando manca la capacità di nominare le cose e le emozioni, manca un meccanismo fondamentale di controllo sulla realtà, e su se stessi. Questi giovani liberano quindi questi sentimenti in un unico modo: la violenza fisica, sugli altri e/o su se stessi. Il fenomeno è noto, nelle scienze cognitive, come ipocognizione e risale a studi degli anni ’50 quando, nel tentativo di individuare le ragioni dell’elevatissimo numero di suicidi registrati a Tahiti, si scoprì che i tahitiani avevano parole per descrivere il dolore fisico ma non quello psichico. Quando questo si presentava, essi non erano in grado di identificarlo e quindi, nei casi gravi, non comprendendolo, li portava al suicidio. Nel frattempo si sono aggiunte anche altre forme di “autolesionismo”: anoressia, bulimia, tossicodipendenza, ecc… Ma torniamo ora alla violenza sui terzi partendo da due casi recenti, presi arbitrariamente, tra i sempre più crescenti anche nella nostra realtà più vicina. Mi riferisco, da un lato, al caso degli studenti ginevrini che lo scorso 8 novembre, a Roma, hanno aggredito un cameriere e sono ora in attesa della sentenza italiana, pur avendo fatto rientro a casa nel frattempo, e dall’altro lato, ai tre studenti zurighesi che recentemente sono stati condannati in prima istanza dal Tribunale dei minori di Monaco per aver aggredito, nell’arco di poche ore, prima 3 disoccupati seduti in un parco, poi quasi ammazzato di botte un passante e infine picchiato uno studente bulgaro. Quest’ultimi, tuttora detenuti in Germania, sono stati condannati a 7 anni, rispettivamente 4 anni e 10 mesi e 2 anni e 10 mesi. Dalle cronache giornalistiche di questi due casi si legge che tutti i minorenni provenivano da buone famiglie svizzere e che nessuno di loro è stato sostanzialmente in grado di descrivere le ragioni che li avevano indotti a questi gravi e gratuiti gesti. Non hanno avuto le parole per dirlo alle autorità e quel che rischia di essere ancora più grave, temo, non hanno avuto le parole per descriverlo a se stessi. La condanna germanica, seppur nei limiti legislativi concessi, è stata giudicata esemplare. Quella italiana si vedrà. Come sempre in queste circostanze, la società, la politica, i genitori ma anche gli esperti si dividono nelle varie opinioni: vi sono quelli che, pur di non assumersi almeno parte delle proprie colpe, cercano di scaricare la responsabilità sugli altri, come accade talvolta da parte di alcuni genitori verso la scuola, i docenti o quell’entità astratta (e quindi di comodo) che è la società. Società che poi siamo noi tutti. Vi sono poi quelli che ritengono di strumentalizzare questi casi eccezionali, a fini politici, per criticare la giustizia svizzera (attentando peraltro alla separazione dei poteri) e per chiedere un inasprimento delle pene. Infatti, la giustizia penale minorile in Svizzera prevede una pena massima di 4 anni accompagnata da misure di rieducazione mentre che in Germania un minorenne può essere condannato a pene fino al 10 anni. Secondo interviste rilasciate dai Tribunali dei minorenni svizzeri e in base a dati statistici, la differenza è che, da noi, i rischi di recidiva si riducono al 35% mentre che in Germania raggiungono l’80 %. Per cui, se potrebbe apparire pagante politicamente, di questi tempi, auspicare che questi giovani delinquenti vengono semplicemente sbattuti in carcere più a lungo, in realtà ciò non pare risolvere il problema alla fonte ma solo ci si libera la coscienza. Scopo della pena è senz’altro, e ci mancherebbe, di “risarcire” la vittima. Ma scopo della giustizia è anche di applicare una sanzione giusta e che abbia a reintegrare il condannato nella società e non solo di allontanarlo/escluderlo il più a lungo possibile per poi ritrovarselo più in là come adulto e forse ancor più emarginato e socialmente pericoloso. La realtà è che il sistema giudiziario non può risolvere, da solo, i problemi. Esso interviene a cose fatte e punisce il singolo. Questo può bastare in una società della responsabilità individuale, ma non quando vi sarebbe da indagare, preventivamente su responsabilità collettive. La giustizia in senso più ampio, come la politica, ci devono portare a comprendere come mai questi giovani della Goldküste zurighese, siano arrivati a tanto, come mai non hanno avuto parole per spiegarsi questo passaggio improvviso e ingiustificato all’azione delittuosa. Come mai oggi questo gruppo di giovani non ha saputo distinguere il bene dal male? Come mai i singoli componenti del gruppo non hanno saputo usare un’altra parola importante che è “No”, “No, io non faccio queste cose e smettetela anche voi!”? Come mai non vi è stata questa reazione immediata di “vergogna” per quanto alcuni “amici” stavano per fare o iniziare a fare? Perché lo spirito di gruppo ha prevalso sul libero arbitrio, sulla capacità e forza di “scegliere”? Perché non si sono percepite le gravi conseguenze prima ancora che si formasse semplicemente il pensiero di passare all’atto? Se questi atti sono una forma di ribellione, allora interroghiamoci sulle ragioni profonde di questa forma negativa di reazione al malessere e cerchiamo di tramutare queste energie in forme positive. In questo senso il compito spetta non tanto o solo alla scuola, ma anche ai genitori. V’è gran bisogno di un patto educativo nuovo, un ritorno alla parola e all’ascolto.